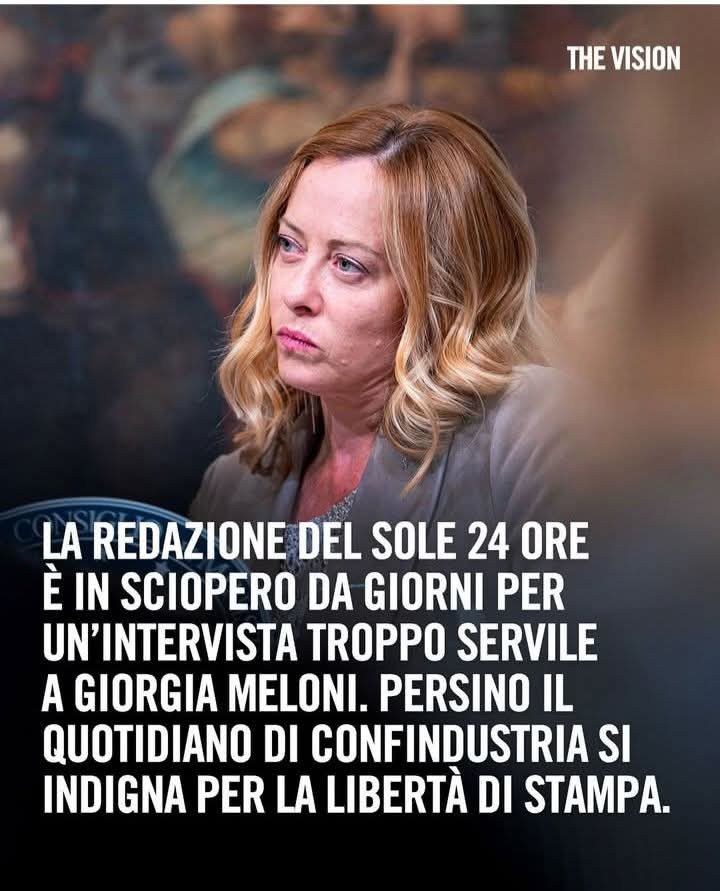Quando perfino Il Sole 24 Ore – giornale di Confindustria e ossatura ideologica del capitalismo produttivo italiano – entra in conflitto con il potere politico, significa che la macchina dell’egemonia si è incrinata. Quel quotidiano non è soltanto un prodotto editoriale: è il luogo simbolico in cui la borghesia nazionale rielabora la propria immagine, lo spazio dove l’impresa diventa linguaggio. Se questa voce comincia a incrinarsi, se denuncia la chiusura autoritaria della comunicazione governativa, allora è lo stesso blocco padronale a percepire la perdita di equilibrio fra capitale e Stato.
L’episodio è noto: la redazione del Sole 24 Ore proclama uno sciopero contro la decisione della direzione di pubblicare un’intervista a Giorgia Meloni affidata a una giornalista esterna, scelta al di fuori della redazione. Lo sciopero viene ignorato, il giornale esce comunque, e i redattori lo definiscono “indecoroso”. È una rottura senza precedenti nella storia della testata, segno della tensione crescente fra la stampa economica e il potere politico. Meloni non concede interviste: costruisce rappresentazioni di sé stessa. Ogni apparizione è una messa in scena calibrata per alimentare un dispositivo carismatico di identificazione collettiva. Non accetta domande – le è sufficiente la cornice. Il giornalismo, in questo quadro, diventa scenografia del comando. È questa teatralità autoritaria, più che il contenuto politico, ad allarmare la borghesia produttiva: l’impossibilità di una mediazione razionale con un potere che comunica soltanto per autorappresentarsi.
Confindustria aveva investito su Meloni con obiettivi concreti: riduzione fiscale per le imprese, riforme del lavoro, gestione efficiente dei fondi PNRR, stabilità nei rapporti internazionali. In cambio la premier avrebbe ottenuto legittimazione e copertura simbolica da parte della grande industria. Ma l’equilibrio si è rotto.
Il governo, più attento alla propaganda che alla pianificazione, ha scelto l’autocelebrazione come metodo. Le decisioni economiche sono discontinue, annunciate prima di essere definite, e la comunicazione ha sostituito la razionalità.
I dati aggravano la frattura: nel 2024 la crescita del PIL si è fermata all’1%, la produttività industriale è calata, l’export europeo è in contrazione, il costo energetico resta superiore alla media UE e il debito pubblico ha raggiunto il 141% del PIL. Numeri che allarmano il capitale perché mettono in discussione la sua capacità di pianificare e di attrarre investimenti. La borghesia non ama l’imprevedibilità, nemmeno quando si veste di ideologia nazionale, da funzione di Stato. Preferisce la stabilità del profitto, non la teatralità del consenso.
La crisi non è solo economica: è linguistica. Il linguaggio tecnico e razionale del capitale si scontra con quello mitologico del potere politico. Il primo parla di bilanci e produttività, il secondo di patria e orgoglio. È la vecchia tensione del capitalismo italiano: l’apparato produttivo pragmatico contro l’apparato politico paternalista.
Per decenni Il Sole 24 Ore ha tradotto le esigenze del capitale in linguaggio politico, fornendo al potere un lessico di legittimazione “tecnica”. Ora quella funzione è superflua. Meloni comunica senza mediazioni, rivolgendosi direttamente al “popolo” e scavalcando la borghesia. Così il capitale si accorge di non essere più soggetto ma oggetto del potere, ridotto a cornice decorativa del proprio mito. L’imprenditoria che credeva di dettare la linea si ritrova espropriata del suo ruolo dirigente, trasformata in componente subalterna della sovrastruttura.
La premier, nel suo rapporto con i giornalisti, ha incarnato questa metamorfosi. “Non voglio mai parlare con la stampa” – ha detto in un fuorionda alla Casa Bianca. Non un lapsus, ma una dichiarazione di metodo. La stampa non serve più a mediare ma a riflettere. Se la relazione politica si trasforma in monologo, il giornalismo diventa ornamento e l’egemonia si fa verticale, autorappresentativa, chiusa. Il Sole 24 Ore ha compreso la deriva: dietro la “leadership forte” riconosce l’erosione del principio liberale che garantiva al capitale libertà di manovra.
Nel linguaggio marxista si potrebbe dire che è saltata la “sovrastruttura organica” del capitale italiano, quella che consentiva alla borghesia di esercitare direzione economica e morale. La stampa economica non è più apparato ideologico dello Stato ma corpo separato, spaesato, privo di corrispondenza con il potere politico. Meloni non governa per il capitale, ma attraverso i suoi simboli, svuotandoli di senso. Parla di impresa, merito, lavoro, ma per costruire consenso. È un uso simbolico dell’economia, non strutturale. La destra padronale teme questo slittamento verso un modello personalistico e centralizzato del potere, perché sa che ogni concentrazione carismatica finisce per divorare la razionalità economica che l’ha generata.Il capitalismo italiano, da sempre ibrido tra mercato e Stato, industria e rendita, ha delegato alla stampa economica la funzione regolatrice del linguaggio borghese. Oggi quella lingua non regge più. Il governo ha sostituito la razionalità economica con la teatralità del potere, riducendo la pianificazione a narrazione. È la forma tipica del comando in crisi: l’autorità politica tenta di supplire alla perdita di consenso con la messa in scena della propria forza. In questa rappresentazione permanente la decisione economica si trasforma in liturgia e la programmazione in propaganda. Il linguaggio della produttività viene svuotato del suo contenuto materiale e riutilizzato come strumento di dominio simbolico.Da qui il disagio crescente del Sole 24 Ore. I suoi editoriali oscillano tra l’allarme e la prudenza: denunciano la perdita di credibilità internazionale, criticano la retorica anti-europea, segnalano l’assenza di riforme. Non è opposizione politica ma difesa di classe. Il giornale dei padroni avverte che il governo rischia di intaccare i presupposti del profitto. È la frattura fra capitale e Stato: un conflitto tra chi produce valore e chi gestisce immagine.
Questo conflitto si riflette nella libertà di stampa. Quando il potere riduce la parola a devozione, non colpisce soltanto i giornalisti: erode l’intera rete di mediazioni su cui si fonda l’egemonia borghese. La parola, che un tempo serviva a ordinare il consenso e a misurare la distanza tra forza e rappresentazione, diventa oggi una materia passiva, un gesto che conferma ciò che già è stato deciso. La stampa, in questo processo, non agisce più come spazio di contraddizione ma come ingranaggio di coesione. Meloni trasforma il linguaggio in voce unidirezionale del potere, e nel farlo dissolve l’idea stessa di mediazione.
La svolta autoritaria chiude ogni spazio di contraddizione. La stampa viene riassorbita nell’orbita del potere come apparato di conferma. Ogni intervista si riduce a rituale, ogni apparizione a ripetizione del dominio. La premier non comunica: impone la parola come atto di governo.
La svolta autoritaria si manifesta nella chiusura del circuito comunicativo, dove ogni intervista assume la forma di una cerimonia e ogni apparizione diventa parte del rito del potere. La premier non dialoga: parla da un palcoscenico che coincide con il governo stesso, in un linguaggio che si piega alla funzione di dominio. È in questa verticalità della parola che la comunicazione perde la propria sostanza critica e torna a essere puro strumento di mantenimento dell’ordine.
Siamo davanti alla personificazione del capitale nella sua fase ideologica matura. Il potere parla di produttività mentre consuma la produzione reale, evoca il merito mentre accentra il controllo e celebra la nazione mentre dissolve il corpo sociale nei dispositivi della concorrenza e della paura. La rappresentazione diventa la forma della realtà economica, la ingloba e la riplasma secondo le esigenze del potere.
Qui la sovrastruttura mostra la propria autonomia apparente: l’egemonia si ritrae e lascia affiorare la struttura nuda del dominio. Lo Stato non media più tra capitale e società, ma dirige direttamente la forza-lavoro e il linguaggio. La pianificazione si riduce a immagine, la previsione è filiera della propaganda, e la parola del capo diventa il meccanismo attraverso cui il potere riorganizza la percezione del reale.
Questa non è fede ma subordinazione sistemica: il tentativo del capitale politico di mantenere coesione mentre il capitale economico perde egemonia. Tutto ciò che appare come forza della leadership è la crisi amministrata della borghesia italiana, costretta a trasformare la rappresentazione in strumento di sopravvivenza.
Il Sole 24 Ore, nel suo sciopero, riflette la paura di una classe dirigente che teme di perdere non solo il controllo dei processi economici ma la capacità di nominare il reale. Quando la politica rifiuta le domande e riduce la stampa a decorazione, il capitale capisce che la propria egemonia non è più garantita. La protesta del giornale padronale non è gesto democratico ma riflesso di autoconservazione: la borghesia difende la libertà di parola come difenderebbe un mezzo di produzione, perché nella parola riconosce la condizione della propria direzione sociale.
Ogni fase storica del capitale produce il proprio linguaggio: nel fordismo la parola era pianificazione, nel neoliberismo comunicazione, oggi è amministrazione del senso. Il potere non regola più soltanto la produzione materiale: governa la produzione simbolica, il tempo dell’attenzione ma soprattutto la misura dell’ascolto. L’informazione è diventata terreno di estrazione di valore e insieme di disciplina. Quando la parola diventa merce, la libertà di parola si riduce inevitabilmente a privilegio.
La frattura tra Il Sole 24 Ore e il governo Meloni, e l’attentato a Ranucci, esprimono la stessa crisi: la perdita di controllo del linguaggio. Nel cuore della crisi, il capitale produttivo non trova più nella politica la traduzione dei propri interessi, e la politica, a sua volta, non riesce più a controllare la parola senza trasformarla in rumore. Ne risulta una società sospesa nella parola sorvegliata, dove l’eccesso di suono coincide con l’assenza di voce.
La crisi d’egemonia, come insegnano Marx e Gramsci, si rivela innanzitutto nel linguaggio. Quando la classe dirigente non riesce più a nominare la realtà dentro la propria logica d’utile, la lingua dominante si svuota e perde la sua funzione storica. Oggi la parola del potere scorre senza direzione, riempie il vuoto che dovrebbe spiegare, sostituisce il pensiero con la ripetizione. L’autorità parla per mantenere in vita l’apparenza della produzione reale, mentre dietro la superficie del discorso si consuma il silenzio della realtà materiale.
La borghesia italiana, abituata al linguaggio tecnico-manageriale, è spiazzata da una politica che non argomenta ma performa. Il populismo di governo non è alternativa alla borghesia: è la sua degenerazione spettacolare, la forma che assume quando l’egemonia si consuma e il dominio resta. La democrazia sopravvive come scena, non come funzione.
In questo contesto la libertà di stampa non è diritto astratto ma rapporto di produzione del sapere. Il giornalista precario vive la stessa alienazione dell’operaio industriale: non controlla il proprio tempo né il proprio prodotto. Il linguaggio, un tempo strumento di pensiero, è oggi ingranaggio di valorizzazione cognitiva. Ogni parola, nel capitalismo della comunicazione, è costretta a generare valore di scambio.
Il potere non riduce il linguaggio al silenzio – lo costringe all’opera del linguaggio, trasformandolo in forza produttiva del consenso.
La voce critica non viene soppressa, ma inglobata nel circuito della valorizzazione simbolica, neutralizzata attraverso la propria esposizione.In questa economia della parola, il rumore diventa la nuova forma del controllo e il silenzio l’unico gesto di rottura – il punto in cui il linguaggio, sottraendosi al ciclo del profitto, ritrova la propria sostanza materiale e politica.
Eppure, proprio qui, nel linguaggio mercificato, può nascere una contro-egemonia. Non come nostalgia del giornalismo libero ma come pratica materiale del lavoro vivo. Quando la parola diventa forza produttiva, la sua liberazione diventa parte della lotta di classe. La classe non si definirà più – solo – per il salario ma per la capacità di dire il mondo contro la narrazione del potere. La battaglia per la libertà di stampa è la nuova forma della lotta per la proprietà dei mezzi di comunicazione, come un tempo – speriamo non tramontati – per i mezzi di produzione.
Creare spazi autonomi di parola – redazioni collettive, laboratori di contro-informazione, comunità di inchiesta e scrittura condivisa – significa restituire al linguaggio la sua funzione materiale: produrre coscienza. In un sistema in cui la verità non nasce dalla pratica comune, ma viene estratta come merce, il gesto più radicale è restituirle la sua natura di lavoro. La verità non è un’opinione né un valore morale: è un processo materiale, una produzione sociale. Quando torna a essere frutto del lavoro vivo e non oggetto di consumo, diventa la forma più alta della lotta di classe.
Il capitalismo mediatico teme la memoria. Dissolve la durata, moltiplica gli eventi, sostituisce la profondità con la velocità.
Ogni notizia è un frammento che consuma la precedente, un istante che cancella la storia per riprodurre l’eterno presente della merce.Ma non esiste trasformazione senza memoria – ricordare è il primo atto di resistenza, perché ricordare significa riconoscere le cause materiali della sofferenza e non soltanto i suoi effetti.
La memoria è la forma politica del tempo: ciò che restituisce al presente la sua genealogia e al futuro la possibilità del mutamento.
Ranucci, con i suoi limiti, diventa segno di questa frattura: la violenza che lo ha colpito mostra quanto sia sottile il confine tra lavoro cognitivo e punizione simbolica. Il Sole 24 Ore, con il suo sciopero, mostra che persino il capitale teme di perdere la propria narrazione. Entrambi disvelano la paura del potere – la paura della parola che eccede l’ordine e del silenzio che non si lascia governare.
L’Italia vive una governamentalità dell’immagine: il potere parla attraverso la scena, non attraverso il progetto. Ma ogni scena, prima o poi, produce il suo rovescio. L’immagine consuma sé stessa e, nella frattura tra rappresentazione e realtà, riemerge la verità materiale. In quella frattura può nascere un nuovo linguaggio di classe.
Non sarà un linguaggio puro, ma vivo, pieno di scarti e conflitti, come la realtà che lo genera. Sarà la lingua di chi lavora, di chi pensa, di chi scrive, di chi traduce. Un linguaggio che non spiega il mondo al potere, ma lo restituisce a chi lo produce.
La libertà di stampa non è un residuo del liberalismo: è il nome presente della lotta per l’autonomia del lavoro vivo.
L’unica libertà reale sarà quella di dire ciò che il capitale non può trasformare in profitto.
E quando quella parola tornerà a essere comune, la storia – di nuovo – tornerà a parlare.
You may also like
-
Nel cuore della città, tra i flussi turistici e le vetrine del lusso, un gruppo di lavoratori interrompe per un giorno la consuetudine del “decoro fiorentino”
-
Ogni epoca di crisi produce figure che ne rappresentano la transizione.
-
La lotta per la casa è una lotta per la vita
-
Il 18 ottobre 2025, a Firenze, non si è trattato di una semplice rivendicazione vertenziale
-
A Gaza la cosiddetta “pace” non segna la fine della guerra, ma la sua metamorfosi strutturale.